Discorso sulla didattica della Shoah
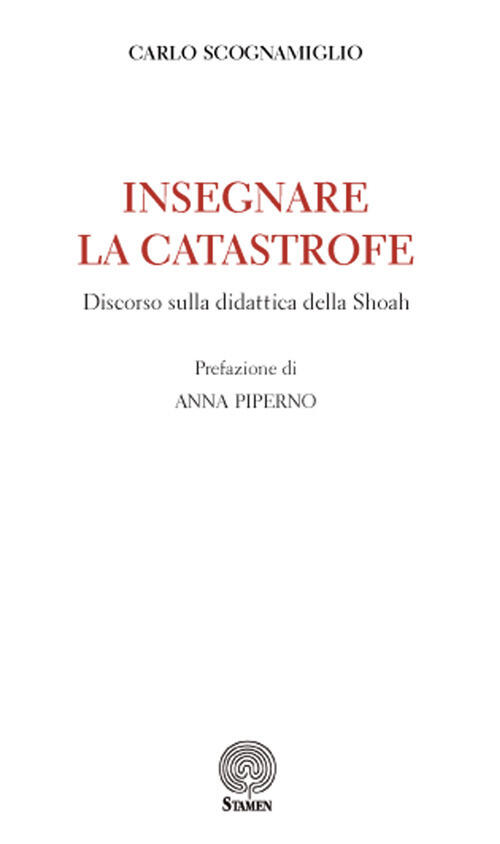 Di Carlo Scognamiglio
Di Carlo Scognamiglio
Ed Stamen, 2017 pp.118
Siamo dinanzi ad un testo importante per chi vuole spiegare una vicenda, tanto terribile e dolorosa per l’umanità, ai giovani
di oggi, nel tempo in cui stanno venendo meno i testimoni diretti
dell’Olocausto, che ha inghiottito milioni di uomini e di donne.
La “didattica
della Shoah” è un tema che non può essere più tralasciato, in quanto, fino ad
oggi abbiamo avuto la testimonianza diretta dei superstiti alla Shoah. Testimoni, sempre meno data l'età elevata dei sopravvissuti, che
ancora si recano nelle scuole, viaggiano cercando di incontrare più studenti e
persone possibili, per raccontare tutta la violenza e la disumanità di quanto
abbiano subìto tutti i “diversi” dalla cosiddetta “razza ariana”.
L’autore cita
subito il ruolo educativo e storico-culturale riconosciuto al Museo dello Yad Vashem di Gerusalemme, luogo dove sono raccolte tutte le storie delle vittime di
questo immenso crimine.
Molto interessante il taglio
utilizzato nel libro, in quanto non si limita ad una narrazione degli orrendi
fatti vissuti nei campi di sterminio, ma scende nei dilemmi morali in cui
rimanevano legate le vittime, ma anche le circostanze che narrano le
decisioni di coloro che erano gli aguzzini morali e materiali. Così facendo, l'autore non sottende responsabilità e ruoli dei
singoli, come anche la responsabilità collettiva, che porteranno verso quella che sarà una
catastrofe immane.
Scognamiglio, da subito, sottolinea la vocazione
“universalistica” della memoria della Shoah: gli ebrei erano il primo bersaglio
della “soluzione finale”, non gli unici.
L’impegno dell’autore è nel cercare una didattica
adeguata per spiegare agli studenti dei diversi cicli non esclusivamente la
narrazione storica degli episodi, quanto la logica, lo sforzo che i nazisti
fecero per cancellare la memoria storica dei perseguitati. Questo per dare modo
agli studenti di avere gli strumenti per entrare nel “perimetro esistenziale di
quel destino”, a cui erano condannate le vittime dai nazisti.
In modo che, i ragazzi, oltre al provare
compassione, possano quasi immedesimarsi nelle vittime e capire quasi dal di
dentro l’angoscia, i patimenti e soprusi subiti.

Seppur folle, disumana, e distruttiva, la
Shoah, però non è inspiegabile: l’autore lo dice chiaramente, citando e ripercorrendo gli scritti e il pensiero storico di coloro che non rinnegarono il nazionalsocialismo né
il nazifascismo, ma ne giustificarono l'opera, quando addirittura non incitavano alle
persecuzioni. Ma, vi furono pure autori perseguitati che sopravvissero per divenire poi narratori, testimoni; come, anche, ci furono coloro che non
presero posizione. Infine, dobbiamo citare anche i cosiddetti “segnalatori
d’incendio”, cioé pensatori e scrittori che denunciarono il pericolo della deriva
antisemita che stava incendiando tutta la società.
Tutto questo lavoro culturale serve all’autore
per sostenere che la catastrofe ebraica non è oltre la storia, non è “extratemporale”,
ma porta a far ammettere che l’uomo è capace di simili crudeltà, e una tale
capacità è potenzialmente presente in ciascuna persona e, come è presente, allora così sono spiegabili tanti atti di crudeltà.
Un’altra operazione dell’ideologia nazista ricordata dall’autore è nella legittimazione che i nazisti diedero al loro odio, giustificando così le loro raccapriccianti azioni: rappresentando, cioè, le vittime come “subumani”,
“ignobili”, “inferiori”, quindi indegni di vivere.
Per contestualizzare, l’autore cita i fenomeni contemporanei di bullismo: i tratti personali delle vittime dei bulli danno la
vocazione alla subalternità: come se la sorte di
essere sottomessi da qualcun altro
Altro aspetto citato è il “conformismo”, prendendo in prestito e citando gli studi e le opere di Bauman, Goldhagen ed Hilberg. Lo sterminio fu
possibile, non solo per un’ostilità, un sentimento antiebraico diffuso nei
tedeschi, quanto anche per una più diffusa indifferenza, se non proprio una diffidenza verso i ... "diversi".
Un'altra idea diffusa che il volume smonta è
quello dell’“italiano brava gente”, che non ha collaborato con i nazisti, ma che anzi, tutti abbiamo nascosto e difeso i perseguitati. Come anche l’idea che il fascismo non ebbe le responsabilità dell’alleato
nazista.
La verità è che i i due regimi collaborarono
per la Soluzione finale, e tranne qualche caso isolato, mai nessun gerarca
fascista si oppose alla deportazione dei "non ariani".
L’autore parla dei materiali didattici presenti
allo Yad Vashem per gli alunni delle scuole primarie, preparati con accorgimenti
che permettono di spiegare concetti e vicende, altrimenti difficilmente
immaginabili. La stessa idea di appartenenza ebraica, in quanto la vita di
prossimità con gli ebrei in molte città europee si è interrotta a causa della
guerra e non si è ricostituita, è un concetto complesso da spiegare in astratto.

Una novità la si registra con le difficoltà per
i discendenti delle vittime della persecuzione nazista, cioè i figli o i nipoti
di coloro che hanno vissuto la persecuzione nazista o anche la reclusione e la
deportazione. L’autore si sofferma a ragionare sul possibile comportamento da
tenere con i bambini, se tenerli all’oscuro degli episodi più tremendi o se,
invece, dare tutte le informazioni chieste da bambini sempre più curiosi.
Alcuni studiosi hanno elaborato la tecnica del
racconto teatrale, per provare ad aumentare il distacco, perché la paura può
essere un fattore determinante per avere o meno un quadro lucido degli
avvenimenti. Qui, forse, possiamo trovare le pagine più “originali” del volume.
C’è poi il problema della complessità della
storia da far comprendere ai ragazzi sulla didattica della Shoah, perché l’Olocausto
storicamente non ha vissuto una sua linearità nell’applicazione, ma fu il “risultato
di un sistema intessuto di piccole iniziative, illuminate da un impianto
ideologico forte, che esigeva un’adesione fideistica”, annota Scognamiglio. Inoltre,
i nazisti si impegnarono per cancellare più prove possibili dei loro misfatti,
ma i testimoni, nonostante l’oppressione e il tentativo di annientare le menti
oltreché i corpi dei deportati, non riuscì. Tantissimi furono i testimoni.
L’autore porta l'esempio di un famoso studioso: lo
psicanalista austriaco Bruno Bettelheim che fu rinchiuso per alcuni mesi nel campo
di Dachau, vivendo direttamente la deportazione, la degradazione e la tortura,
ma che riuscì a salvarsi dalla morte.
Da internato, nonostante le privazioni e le torture, riuscì a compiere uno studio molto interessante sulla condizione dei prigionieri, osservando e registrando le variazioni dei loro comportamenti nel tempo.
Da internato, nonostante le privazioni e le torture, riuscì a compiere uno studio molto interessante sulla condizione dei prigionieri, osservando e registrando le variazioni dei loro comportamenti nel tempo.
Le ultime pagine del volume, l’autore le dedica
ai sopravvissuti e racconta cosa hanno fatto dopo la liberazione: in alcuni
tratti la narrazione è sorprendente, mai ci si attenderebbe quanto l’autore
scrive nelle ultime due pagine in merito alle vicende di coloro i quali riuscirono a sopravvivere a tanto male.
In conclusione, ritengo la lettura di questo volume molto
istruttiva, non solo per chi abbia figli giovani o incarichi di didattica,
ma per tutti coloro che sanno di non sapere mai a sufficienza e di non aver ancora
imparato tutto della vita!
Così saprete anche cosa l’autore scrive al
termine del suo libro che - ripeto - consiglio a tutti di leggere…
Germano Baldazzi
15 marzo 2018

